
Il Caso della Formula del Polipropilene Perduta a Milano. Capitolo 7: Misteri a Corenno Pliniodi Marco ArezioDopo aver concluso una serie di colloqui cruciali per l'indagine, il commissario Lucia Marini decide di stabilirsi temporaneamente a Corenno Plinio, scegliendo come base un piccolo hotel dal fascino discreto e accogliente, affacciato sulle placide acque del lago. L'edificio, un'antica costruzione in pietra rimodernata per accogliere i visitatori, si trovava a pochi passi dal castello, il fulcro della sua indagine. Il gestore dell'hotel, un uomo cordiale e affabile di nome Paolo Ferrario, accolse Marini con un misto di sorpresa e onore. Paolo: "Benvenuta all'Hotel Belvedere, commissario Marini. È un onore per noi ospitarla. Qui potrà godere di una magnifica vista sul lago dalle nostre terrazze e dalle stanze. Offriamo anche un servizio di ristorazione con piatti tipici della cucina lombarda, che spero avrà il piacere di assaggiare. Se desidera rilassarsi, il nostro giardino sul retro offre un angolo di pace perfetto per leggere o semplicemente per ammirare il panorama del lago e del castello, un monumento con una storia affascinante. Per qualsiasi esigenza, il nostro personale è a sua disposizione." La stanza assegnata a Marini è ampia e luminosa, con un letto matrimoniale adornato da lenzuola di lino fresco e un balcone privato che si affaccia sul lago, offrendo una vista mozzafiato che sembra fondersi con l'orizzonte. Dopo essersi sistemata, Marini trascorre un momento di rilassatezza sul balcone, lasciandosi cullare dalla brezza leggera che porta con sé i profumi del lago e il suono soffuso delle onde. Una volta sistemata, Marini scese nella veranda dell'hotel, un angolo di pace con vista sul lago, dove decise di approfittare dell'ospitalità di Paolo per saperne di più sul castello di Corenno Plinio. Marini: "Paolo, mi raccontava che questo castello ha una storia affascinante. Cosa può dirmi della sua fondazione e delle leggende che lo circondano?" Paolo: "Ah, il castello! È una delle gemme di Corenno Plinio. Fondato nel XII secolo, ha visto passare signori feudali, battaglie e persino monaci. In origine, era un avamposto militare, poi divenne una residenza signorile. Ogni pietra di quelle mura racconta una storia." Lucia ascoltava, affascinata, mentre Paolo continuava, descrivendo le varie fasi della vita del castello, dal suo ruolo difensivo durante le lotte tra fazioni locali alla sua trasformazione in luogo di ritiro spirituale. Paolo: "Ma una delle storie più intriganti riguarda i cunicoli segreti. Si dice che sotto il castello ci sia una rete di passaggi nascosti, costruiti per sfuggire in caso di assedio o per condurre attacchi sorpresa. Alcuni affermano di averli visti, ma sono pochi e nessuno è mai riuscito a mapparli completamente." Lucia: "Cunicoli segreti, dice? Questo è estremamente interessante. Sono mai stati utilizzati per scopi... meno nobili?" Paolo: "Le leggende parlano di tesori nascosti, prigionieri fuggiti e persino incontri clandestini nei secoli passati. Ma, sa, sono storie che si perdono nella notte dei tempi. Chi può dire quanto ci sia di vero?" Il racconto di Paolo sui cunicoli segreti accese l'immaginazione di Marini, spingendola a considerare nuove possibilità nell'ambito della sua indagine. Se questi passaggi nascosti fossero stati utilizzati di recente, potrebbero fornire un'importante chiave di volta per comprendere le attività sospette legate al castello. Marini: "Grazie, Paolo. La sua conoscenza del castello e delle sue storie è stata illuminante. Potrebbe esserci più di una semplice leggenda dietro a questi racconti." Nella terrazza dell'Hotel Belvedere, con la brezza serale che accarezza dolcemente il lago, il commissario Lucia Marini si concede un momento di pausa dall'intensità delle sue indagini. La cena inizia con un antipasto di formaggi locali, accompagnati da un miele aromatico e noci croccanti, che preparano il palato per le delizie a seguire. Come piatto principale, Lucia sceglie risotto alla milanese, un classico intramontabile della cucina lombarda, la cui cremosità e il sapore ricco dello zafferano si fondono in un abbraccio di gusto autentico. Accompagna il pasto con un bicchiere di vino rosso della Valtellina, che con il suo carattere robusto ma equilibrato, completa perfettamente la cena. Consci di offrire a Marini un fine settimana di relax dopo i suoi impegni investigativi, Paolo le suggerisce alcune attività per approfittare al meglio dei due giorni liberi. Paolo: "Visto che ha il fine settimana libero, commissario, potrebbe interessarle fare una gita in battello o in corriera per esplorare le bellezze del lago. Le consiglierei anche di visitare la Villa Monastero a Varenna, un gioiello di architettura e giardini botanici. E se ama le passeggiate, il Sentiero del Viandante offre panorami indimenticabili. Infine, non può lasciare il lago senza aver visitato Bellagio, la 'perla del lago', con i suoi suggestivi vicoli e botteghe artigiane." Lucia ringrazia Paolo per i suggerimenti, sentendosi già avvolta dall'atmosfera magica del lago. Quel fine settimana promette di essere un'occasione per ricaricare le energie, immergendosi nelle bellezze naturali e storiche che solo il Lago di Como può offrire. Con la mente ancora impegnata nelle indagini, sa che quei momenti di pausa saranno fondamentali per affrontare con rinnovato vigore le sfide che la attendono. Dopo aver concluso la cena con un sorso di grappa, per onorare la tradizione locale, Lucia si dirige alla piccola biblioteca dell'hotel, dove sceglie un libro che promette di essere la compagnia perfetta per la serata. Con il libro in mano, sale in camera, dove l'attende un ambiente caldo e accogliente, illuminato dalla soffusa luce di una lampada da tavolo. Seduta sul morbido divano della sua stanza, con il lago che si estende tranquillo al di là del balcone, Lucia apre il libro ma si rende conto che la sua mente è altrove. Lasciando da parte la lettura, inizia a riflettere sull'indagine, cercando di collegare le informazioni raccolte durante i colloqui con il sindaco Giorgio Albertini, il maresciallo Marco Valenti e il dottor Francesco Branchini. Dal sindaco Albertini, aveva percepito una certa reticenza, quasi come se nascondesse qualcosa riguardo al castello e alle attività che vi si svolgevano. Il maresciallo Valenti, invece, le aveva fornito dettagli utili sugli spostamenti sospetti nei dintorni del castello, confermando la presenza di individui non del luogo. Infine, il dottor Branchini, con i suoi racconti sulle leggende del castello e sui cunicoli segreti, aveva aggiunto un ulteriore tassello al mistero, suggerendo che sotto la superficie visibile si nascondessero segreti ben più profondi. Lucia inizia a tracciare mentalmente una mappa delle connessioni possibili tra questi elementi. Si chiede se la reticenza del sindaco possa essere legata alla protezione di qualche segreto antico o a interessi personali. Riflette su come i movimenti sospetti segnalati dal maresciallo potrebbero essere collegati ai cunicoli segreti menzionati dal dottor Branchini e su come queste informazioni potrebbero condurla a scoprire la verità dietro l'attività dei Custodi dell'Ombra. Con questi pensieri a farle compagnia, Lucia capisce che l'indagine sta per entrare in una fase cruciale. Sa che le giornate a venire richiederanno tutto il suo acume investigativo e la sua determinazione per portare alla luce i segreti celati nelle ombre del castello di Corenno Plinio. Con una rinnovata sensazione di scopo, decide di riposarsi, consapevole che l'indomani sarà un altro giorno pieno di sfide e scoperte. Il commissario Lucia Marini cerca distrazione dalla sua insonnia accendendo la radio, sentendo alcune notizie del radiogiornale della notte: Lancio di Luna 1: "L'Unione Sovietica annuncia il successo della missione spaziale Luna 1, il primo oggetto umano a raggiungere la vicinanza della Luna, segnando un momento storico nella corsa allo spazio." Apertura della Conferenza di Ginevra: "Si apre a Ginevra una nuova conferenza internazionale con lo scopo di discutere la sicurezza globale e la riduzione delle armi nucleari, vedendo la partecipazione delle maggiori potenze mondiali." Trattato Antartico: "Delegazioni di dodici paesi si incontrano a Washington per firmare il Trattato Antartico, che stabilisce l'Antartide come una zona scientifica neutrale e vieta qualsiasi attività militare sul continente." Avanzamenti in Medicina: "Ricercatori americani annunciano un importante progresso nella lotta contro la poliomielite, con lo sviluppo di un nuovo vaccino più efficace." Rivoluzione Cubana: "Fidel Castro, leader della Rivoluzione Cubana, intraprende ampie riforme agrarie a Cuba, nazionalizzando le terre e promettendo di ridistribuirle tra i contadini." Boom Economico Italiano: "L'Italia continua a sperimentare un periodo di crescita economica senza precedenti, con un aumento significativo della produzione industriale e una crescente prosperità per le famiglie italiane." Elezioni Federali in Germania: "La Germania Occidentale si prepara alle elezioni federali, con il cancelliere Konrad Adenauer che cerca un ulteriore mandato alla guida del paese." Innovazioni Tecnologiche: "La Philips introduce sul mercato il primo registratore portatile di cassette, promettendo di rivoluzionare il modo in cui la musica viene ascoltata e condivisa." Riconoscimento della Letteratura Africana: "Lo scrittore nigeriano Chinua Achebe guadagna riconoscimenti internazionali per il suo romanzo 'Things Fall Apart', considerato un'opera fondamentale nella letteratura africana." Esplorazioni Sottomarine: "Il batiscafo Trieste, progettato per esplorazioni in profondità oceaniche, si prepara per una discesa record nella Fossa delle Marianne, tentando di raggiungere il punto più profondo mai esplorato negli oceani della Terra." Mentre le notizie scorrono nella penombra della stanza, Lucia si ritrova a riflettere sulla rapidità dei cambiamenti che stanno modellando il mondo fuori dalla tranquillità apparente di Corenno Plinio, offrendole una prospettiva più ampia su quanto sia vasto e complesso il contesto in cui si trova a operare. Sabato mattina, dopo una notte ristoratrice, il commissario Lucia Marini si sveglia pronta ad affrontare la giornata. Scende nella sala da pranzo dell'hotel, dove viene accolta dal profumo invitante del caffè appena fatto. La colazione è un ricco buffet che offre il meglio delle specialità locali: Lucia inizia con una fetta di pane fresco, burro e una selezione di marmellate fatte in casa, tra cui spicca quella di albicocche del lago. Accompagna il tutto con una brioche al cioccolato, soffice e appena sfornata. Non manca di gustare un caffè espresso, forte e corposo, seguito da un bicchiere di succo d'arancia fresco. Dopo la colazione, Lucia si avvicina al gestore, Paolo, per chiedere informazioni sui trasporti. Marini: "Buongiorno, Paolo. Potrebbe dirmi a che ora passa la corriera per Varenna? Vorrei visitare la Villa Monastero, come mi ha suggerito ieri." Paolo: "Certamente, commissario. La corriera per Varenna passa proprio qui vicino alle 9:30. È un breve viaggio, e le consiglio di arrivare qualche minuto prima per assicurarsi il posto migliore per godersi il panorama lungo la strada." Ringraziando Paolo per le informazioni, Lucia si prepara per la sua gita. Arrivata a Varenna, una pittoresca cittadina affacciata sul lago, si dirige direttamente a Villa Monastero, dove prenota una visita guidata. La guida, una ragazza esperta e appassionata di storia e arte, accoglie Lucia e il piccolo gruppo di visitatori all'ingresso della villa. Guida: "Benvenuti a Villa Monastero, un gioiello di architettura e storia che affonda le sue radici nel Medioevo. Originariamente un convento cistercense, la villa ha subito nel corso dei secoli diverse trasformazioni, diventando la magnifica residenza che vedete oggi." Proseguendo nella visita, la guida conduce il gruppo attraverso le varie sale della villa, ognuna arredata con pezzi d'epoca e opere d'arte che raccontano la ricca storia della dimora e delle famiglie che l'hanno abitata. Guida: "Ogni stanza qui a Villa Monastero ha la sua storia unica, dai soffitti affrescati ai pavimenti in marmo. Ma è il giardino botanico che rappresenta la vera meraviglia della villa. Estendendosi per quasi due chilometri lungo la riva del lago, il giardino ospita specie vegetali rare e preziose, alcune delle quali uniche in Italia." Il tour giunge al culmine nel giardino, dove la guida descrive con entusiasmo le varie specie di piante e fiori, le sculture e le fontane che punteggiano il percorso, offrendo una vista mozzafiato sul lago e sulle montagne circostanti. Guida: "Come potete vedere, Villa Monastero è molto più di una semplice casa; è un luogo dove arte, storia e natura si fondono in un'armonia perfetta. Spero che la bellezza e la pace che trovate qui vi restino nel cuore." Dopo la visita guidata, il commissario Lucia Marini avvicina la guida, una giovane ragazza del paese di nome Chiara, con un'aria di curiosità e determinazione. Lucia: "Grazie per il tour, Chiara. È stato davvero affascinante. Avrei una richiesta un po' particolare. Sono molto interessata al castello di Corenno Plinio per questioni legate al mio lavoro. Credi che ci sia la possibilità di organizzare una visita lì?" Chiara: "È un piacere, commissario. Per quanto riguarda il castello, purtroppo, non è aperto al pubblico così liberamente come Villa Monastero. Per accedervi, specialmente per una visita approfondita come immagino lei desideri, è necessaria un'autorizzazione specifica." Lucia: "Capisco. E come si potrebbe ottenere questa autorizzazione?" Chiara: "Deve essere concessa direttamente dal sindaco di Corenno Plinio. Lui ha la chiave del castello e gestisce gli accessi. Se vuole, posso parlargli della sua richiesta e vedere se è possibile organizzare qualcosa. Sono sicura che, data la natura del suo interesse, potrebbe essere fatta un'eccezione." Lucia: "Ti sarei molto grata se potessi fare questa richiesta per me. Ecco il mio biglietto da visita; per favore, tienimi informata su qualsiasi sviluppo. La visita al castello potrebbe essere cruciale per il mio lavoro." Chiara: "Naturalmente, commissario. Farò del mio meglio per aiutarla. Le farò sapere non appena avrò una risposta dal sindaco." Con questa promessa di assistenza, Marini ringrazia nuovamente Chiara per la disponibilità e per l'interessante tour. Mentre lascia Villa Monastero, il pensiero di esplorare il castello di Corenno Plinio e scoprire i suoi segreti aggiunge un nuovo livello di anticipazione alla sua indagine. La possibilità di accedere al castello, con la sua storia e le sue leggende, potrebbe rivelarsi un passo decisivo per comprendere meglio gli eventi misteriosi che circondano Corenno Plinio e i Custodi dell'Ombra. Al termine della visita, Lucia si sente arricchita e ispirata dall'esperienza, portando con sé non solo la bellezza di Villa Monastero, ma anche la consapevolezza di quanto sia importante preservare e valorizzare il patrimonio culturale e naturale del proprio paese. Dopo aver trascorso la mattinata tra la storia e i giardini di Villa Monastero a Varenna, il commissario Lucia Marini decide di dedicare il resto della giornata all'esplorazione di questo incantevole paese sulle rive del Lago di Como. La discesa verso il cuore di Varenna la porta lungo antiche scale di pietra, testimoni silenziosi della lunga storia del paese. Ogni gradino sembra raccontare storie di passanti di ogni epoca, mentre Lucia si immerge nella quiete e nel fascino di questo luogo. Varenna, con le sue case color pastello, le piccole piazze ombreggiate e i vicoli stretti, rappresenta l'essenza della vita lacustre italiana. Lucia inizia la sua esplorazione dalla riva del lago, dove i piccoli battelli oscillano dolcemente sull'acqua cristallina, sotto lo sguardo benevolo delle montagne che circondano il lago. La prima tappa è il lungolago, un sentiero lastricato che costeggia l'acqua e offre viste spettacolari. Lungo il cammino, Lucia ammira le ville eleganti nascoste tra la vegetazione lussureggiante, i giardini curati con amore e i caffè che invitano i visitatori a sedersi e godere della tranquillità del luogo. Si ferma un momento per assaporare un caffè in uno di questi caffè, lasciandosi catturare dalla serenità del paesaggio. Durante la sua passeggiata lungo il porto di Varenna, il commissario Lucia Marini nota il molo riservato agli idrovolanti. L'idea di ammirare il Lago di Como dall'alto la affascina immediatamente, così si avvicina per chiedere informazioni. Il pilota, un uomo di nome Alessandro Bianchi, è appoggiato al suo idrovolante, controllando alcuni dettagli tecnici. Uomo di media età, con i capelli brizzolati tagliati corti e gli occhi che brillano di passione per il suo lavoro, Alessandro si avvicina a Lucia con un sorriso accogliente. Lucia: "Buongiorno, sono interessata a fare un giro del lago con l'idrovolante. Potrebbe dirmi di più sulle gite disponibili e sui relativi costi?" Alessandro: "Certamente, commissario. Offriamo diverse opzioni, dalla breve esplorazione di 20 minuti, che le darà un'idea generale del lago e dei suoi paesi, fino a giri più lunghi di un'ora, dove potrà ammirare dettagliatamente le ville storiche e i giardini che costeggiano il lago. I prezzi variano in base alla durata del volo, partendo da una base di 100 lire per il giro più breve." Lucia è subito attratta dalla possibilità di vedere il Lago di Como da una prospettiva così unica e chiede ulteriori dettagli sul giro più lungo. Alessandro: "Il giro di un'ora è quello che consiglio se ha tempo. Partiremo da Varenna, sorvoleremo Bellagio, proseguiremo fino alla punta del ramo di Como e poi ritorneremo indietro lungo la costa opposta, passando da luoghi incantevoli come Tremezzo e Menaggio. È un'esperienza che le rimarrà nel cuore." Alessandro Bianchi era un ex pilota dell'aeronautica militare che, dopo aver concluso il servizio, decise di trasformare la sua passione per il volo in una professione civile. Amante del Lago di Como, dove aveva trascorso gran parte della sua infanzia, vide nell'idrovolante il modo perfetto per unire il suo amore per il volo con la bellezza del lago. Nel tempo libero, Alessandro era anche un appassionato restauratore di barche d'epoca, e spesso si poteva trovare nel suo piccolo cantiere a lavorare su qualche vecchio scafo, recuperando pezzi della storia lacustre. La sua vita privata era tranquilla e dedicata alla famiglia e agli amici. Nonostante il suo lavoro lo portasse spesso lontano da casa, era profondamente radicato nella comunità locale, contribuendo attivamente alla vita del paese e partecipando alle iniziative di promozione del territorio. Entusiasta all'idea di sorvolare il Lago di Como e in particolare il castello di Corenno Plinio, Lucia Marini si avvicina nuovamente al pilota, Alessandro Bianchi, per finalizzare i dettagli del suo volo. Lucia: "Alessandro, sarebbe possibile durante il sorvolo passare più volte e il più radente possibile sul castello di Corenno Plinio? Sono particolarmente interessata a quella zona." Alessandro: "Certamente, commissario. Possiamo organizzare il percorso in modo da dedicare una particolare attenzione al castello. Per quanto riguarda la quota di volo, rispetteremo tutte le normative di sicurezza, assicurandoci di offrirle la migliore visuale possibile." Lucia: "Perfetto, grazie. Quanto sarà il costo per questa esperienza personalizzata?" Alessandro: "Per un volo personalizzato come quello che ha richiesto, considerando la durata e le specifiche esigenze, il costo sarà di 200 lire. È un'occasione unica per godere delle bellezze del nostro lago da una prospettiva davvero speciale." Soddisfatta dell'accordo e del prezzo estremamente ragionevole, Lucia salda l'importo, anticipando con gioia il volo della mattina successiva. Dopo aver ringraziato Alessandro per la sua disponibilità e professionalità, Lucia si incammina verso la piazza centrale di Varenna, dominata dalla Chiesa di San Giorgio. Decide di visitare questo edificio sacro, un esempio magnifico di architettura romanica, che conserva al suo interno affreschi preziosi e un'atmosfera di pace e spiritualità. Dopo aver esplorato il centro, il commissario si avventura attraverso i vicoli stretti e ripidi che salgono verso la parte più alta del paese. Qui, l'atmosfera cambia, con strade silenziose bordate da case di pietra e piccoli giardini. La tranquillità di questi angoli sembra lontana anni luce dalla frenesia della vita moderna, offrendo a Lucia un momento di riflessione e connessione con il passato. La sua esplorazione la porta infine al Castello di Vezio, che si erge su un promontorio roccioso sovrastante il paese. Sebbene la salita sia impegnativa, la vista che si gode dalla sommità è incomparabile: un panorama a 360 gradi sul Lago di Como e sui paesi circostanti. Qui, tra le antiche mura del castello, Lucia si sente come se potesse toccare con mano la storia, immaginando le vite di coloro che secoli fa abitavano questo luogo. La giornata trascorsa a Varenna, tra storia, natura e adesso l'emozionante prospettiva del volo in idrovolante, ha arricchito l'esperienza di Lucia sul Lago di Como, offrendole non solo un momento di distrazione dalle indagini, ma anche nuovi spunti di riflessione su quanto il paesaggio e la storia del luogo possano essere intrinsecamente collegati al caso che sta seguendo. Mentre la corriera si avvia verso Corenno Plinio, serpeggiando lungo le strade che costeggiano il lago, Lucia si lascia cullare dai pensieri e dalle immagini della giornata, anticipando con un misto di eccitazione e curiosità il sorvolo del castello che potrebbe rivelare nuovi dettagli cruciali per la sua indagine.
SCOPRI DI PIU'
Plastic Free: Una situazione incredibiledi Marco Arezio Il paradosso dell'inquinamento da plastica è che non c'è abbastanza plastica riciclata sul mercato. Pensaci. I movimenti popolari hanno aumentato la domanda di materie prime rigenerate per produrre imballaggi ecologici. I produttori di granuli e macinati riciclati non sono più in grado di soddisfare le esigenze delle industrie dell'imballaggio poiché la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti di plastica sono di gran lunga inferiori alle richieste. La raccolta differenziata e il suo riciclaggio producono troppo poco materiale rispetto a quello che sarebbe necessario e quindi i rifiuti in plastica da riciclare sono lì ma finiscono principalmente nelle discariche o nell'ambiente. Una situazione incredibile.
SCOPRI DI PIU'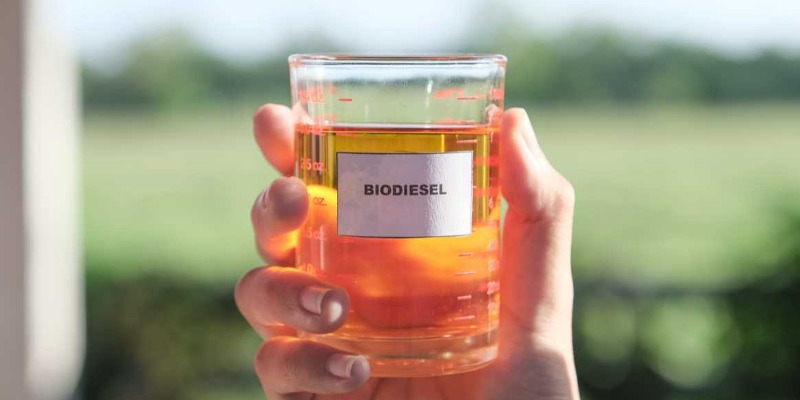
Impegnare risorse e conoscenze per far rendere in modo sostenibile i terreni abbandonati dal sistema agricolo Si è parlato molto dell'utilizzo dei terreni fertili, specialmente in Brasile, per la produzione di coltivazioni che possono essere impiegate per trasformazione in biocarburanti. Il tema è molto attuale in quanto questo sistema è frequentemente additato, insieme all'allevamento intensivo degli animali da carne e alle relative superfici da destinare alla produzione di foraggio per il loro sostentamento, tra maggiori fattori di inquinamento, di deforestazione, di consumo delle risorse idriche e al negativo impatto ambientale dei prodotti chimici necessari ai vari processi. L'agricoltura, necessaria per il sostentamento della popolazione mondiale, sta già facendo i conti con i cambiamenti climatici che stanno causando diffuse desertificazioni, siccità, improvvise alluvioni e migrazioni epocali, quindi, l'idea di un incremento dell'utilizzo dei terreni fertili per la produzione di carburanti verdi sarebbe davvero pericoloso. In questa situazione si inserisce un sistema produttivo di biocarburanti, da distribuire nelle stazioni di rifornimenti, proveniente dai rifiuti e oli vegetali con un'attenzione alle problematiche sopra esposti. Il nuovo carburante in distribuzione si chiama HVOlution, ed è già disponibile in 50 Eni Live Station in Italia, ed entro fine marzo lo sarà in 150. Prodotto da materie prime di scarto e residui vegetali, e da olii generati da colture non in competizione con la filiera alimentare, è già utilizzabile dalle motorizzazioni omologate. HVOlution, il primo diesel di Eni Sustainable Mobility prodotto con 100% di materie prime rinnovabili (ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 “REDII”), è in vendita in 50 stazioni di servizio Eni e sarà disponibile a breve, entro marzo 2023, in 150 punti vendita in Italia. HVOlution è un biocarburante che viene prodotto da materie prime di scarto e residui vegetali, e da olii generati da colture non in competizione con la filiera alimentare. HVOlution può contribuire all’immediata decarbonizzazione del settore dei trasporti anche pesanti, tenuto conto delle emissioni allo scarico, perché utilizzabile con le attuali infrastrutture e in tutte le motorizzazioni omologate, di cui mantiene invariate le prestazioni. Eni è in grado di offrire ai propri clienti questo innovativo biocarburante grazie all’investimento realizzato sin dal 2014 con la trasformazione delle raffinerie di Venezia e Gela in bioraffinerie, che dalla fine del 2022 sono palm oil free. La tecnologia proprietaria Ecofining™ consente, infatti, di trattare materie prime vegetali di scarto e olii non edibili per produrre biocarburante HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, olio vegetale idrogenato) di cui Eni Sustainable Mobility è il secondo produttore in Europa. HVOlution è un biocarburante composto al 100% da HVO puro. Prima della commercializzazione nelle stazioni di servizio Eni, l’HVO in purezza è stato utilizzato da diversi clienti, i quali hanno movimentato dai mezzi per la movimentazione dei passeggeri a ridotta mobilità in ambito aeroportuale fino ai veicoli commerciali della logistica; inoltre, addizionato al gasolio, dal 2016 il biocarburante HVO è presente al 15% nel prodotto Eni Diesel +, disponibile in oltre 3.500 stazioni di servizio in Italia. Stefano Ballista, amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility, ha dichiarato: “Il biocarburante puro HVOlution ha un ruolo fondamentale perché già da oggi può dare un contributo importante alla decarbonizzazione della mobilità, anche del trasporto pesante. Questo prodotto arricchisce l’offerta nelle stazioni di servizio, affiancandosi all’attuale proposta di prodotti low-carbon, come le ricariche elettriche, e di servizi per le persone in mobilità: obiettivo di Eni Sustainable Mobility è integrare gli asset industriali e commerciali lungo tutta la catena del valore, dalla disponibilità della materia prima fino alla vendita di prodotti decarbonizzati al cliente finale.” Eni ha siglato accordi e partnership che permettono di valorizzare gli scarti e i rifiuti utilizzandoli come feedstock per la produzione di biocarburanti come HVOlution. In diversi paesi dell’Africa tra i quali Kenya, Mozambico e Congo, Eni sta sviluppando una rete di agri-hub in cui verranno prodotti olii vegetali in grado di crescere in terreni marginali e aree degradate e non in competizione con la filiera alimentare e, al tempo stesso, di creare opportunità di lavoro sul territorio. Recentemente, dal Kenya è arrivato nella bioraffineria di Gela il primo carico di olio vegetale prodotto nell’agri-hub di Makueni, mentre a Venezia è arrivato il primo carico di olii di frittura esausti. L’obiettivo è di coprire il 35% dell’approvvigionamento delle bioraffinerie Eni entro il 2025. Traduzione automatica. Ci scusiamo per eventuali inesattezze. Articolo originale in Italiano. Fonte: ENI
SCOPRI DI PIU'
Fibra elastica in poliuretano: dagli anni 30 del secolo scorso alla chimica dell’abbigliamento elasticizzato modernodi Marco ArezioSe vogliamo dare una definizione di cosa sia la fibra di poliuretano possiamo dire che è una sostanza chimica sintetica caratterizzata da un comportamento simile alla gomma. Questa fibra è formata da una catena molecolare composta da segmenti molli, detti glicoli, intervallati da segmenti rigidi detti isocianati. La fibra di poliuretano nasce intorno al 1937 quando la tensione politica-militare in Europa rese più difficile il commercio delle materie prime, infatti fino ad allora gli elastomeri erano prevalentemente naturali, importati dal sud America e dal Sud Est Asiatico. Come si può leggere nell’articolo presente nelle NEWS sulla storia della gomma naturale, questa era un elemento conosciuto fin dai tempi dei Maya e utilizzato in tutto il mondo in diversi settori. La vera svolta nel campo dei tessuti avvenne nel 1823 quando Charles Macintosh, brevettò un composto fatto di gomma naturale e di oli, adatto all’impermeabilizzazione dei tessuti e, successivamente nel 1830, Thomas Hancock, sottopose il composto gommoso ad azioni meccaniche, mischiando additivi oleosi, cariche e pigmenti, così da rendere industrialmente lavorale in macchina il compound. Fu un tale successo che le esportazioni dal Brasile della gomma naturale aumentarono in modo esponenziale, passando da poche centinaia di tonnellate del 1846 a più di 10.000 nel 1880. Fu così che gli inglesi fiutarono il business e nel 1876 ottennero, da alcuni semi importati dal Brasile, duemila piantine di Hevea Brasilienis, che furono inviate poi nell’attuale Sri Lanka per essere ripiantate. Questo intervento botanico Inglese fece nascere una fiorente produzione, attiva ancora oggi, in Malaysia, Indonesia e Thailandia, area nella quale si produce oggi l’80% della gomma naturale. Negli anni 30 del secolo scorso, periodo nel quale la ricerca chimica stava facendo passi enormi, iniziarono i primi studi per creare una gomma sintetica replicabile in qualunque paese al mondo, senza dipendere dall’importazione della materia prima naturale. Gli studi più interessanti del periodo furono eseguiti dalla tedesca Bayer e fu così che nel 1939, Paul Schlack, sintetizò un polimero con alte proprietà elastiche, ma si dovette attendere la fine della seconda guerra mondiale per vedere la produzione, nel 1951, della prima fibra poliuretanica attraverso il processo di filatura ad umido. Anche negli Stati Uniti la ricerca portò l’azienda DuPont, a seguito di importanti investimenti fatti sulla fibra elastica in poliuretano, nel 1959, a produrre la fibra poliuretanica elastica, attraverso il processo di filatura a secco, che mise sul mercato nel 1962. La vera esplosione della produzione di questi filati avvenne alla fine degli anni 60 del secolo scorso, quando si diffuse la moda della minigonna e il relativo uso delle calze da donna. Come viene prodotta e lavorata la fibra in sintetica in Poliuretano? La fibra elastomerica sintetica è prodotta estrudendo il polimero poliuretano in soluzione o fuso, utilizzando una filiera di un impianto di filatura meccanica. Vi sono normalmente quattro metodologie per la produzione della fibra: Filatura a umido consiste nell’estrusione del polimero in bagno d’acqua calda, formando il filo per coagulazione, ed il successivo lavaggio, essiccazione, lubrificazione e avvolgimento in bobina. Filatura a secco è indubbiamente il sistema più usato al mondo e consiste nell’estrusione del polimero in una cella cilindrica verticale all’interno del quale è presente un gas caldo, che normalmente è azoto. Il filo passa dalla cella e viene successivamente lubrificato, con olio siliconico o stearato di magnesio e poi arrotolato su una bobina posta alla fine di essa. Filatura per fusione consiste nella plastificazione di granuli in un estrusore creando una messa fluida, la quale viene fatta passare attraverso una filiera in verticale che si incontra con un flusso di aria fredda che porta alla solidificazione della materia prima. Il filo in uscita, viene poi lubrificato e avvolto su bobine. La filatura per fusione, tra i quattro processi presentati, è sicuramente quello a più basso impatto ambientale in quanto non richiede solventi e ha una necessità minore di energia. Filatura reattiva consiste nell’estrusione del pre-polimero in un bagno di soluzione contenente ammine polifunzionali. Le parti di isocianato che costituiscono la materia prima reagiscono con le ammine formando un poliuretano a più alto peso molecolare. È una tecnologia oggi poco usata a causa delle basse caratteristiche elastiche del filo rispetti ad altri procedimenti produttivi. Quali sono le applicazioni principali della fibra in poliuretano? Gli utilizzi di questa fibra sono molteplici, quindi raccogliamo solo alcune indicazioni di produzione degli articoli: – Tovaglie – Copri divani – Calze per uso chirurgico – Bende elastiche – Calze a compressione graduata – Pannolini – Tute per attività sportiva – Mute da sub – Pantaloni da sci e pantacollant – Jeans e altri tessuti elasticizzati – Corsetteria – Calzini e collant – Nastri elastici – E molti altri articoliCategoria: notizie - plastica - economia circolare - PU - fibra elastica
SCOPRI DI PIU'
Il Lavaggio dei Rifiuti Plastici da Post Consumo si Fa in Tredi Marco ArezioI rifiuti plastici da post consumo sono, in termini quantitativi, tra le maggiori voci che compongono il paniere degli scarti che la nostra società produce.Se fino a pochi anni fa non veniva applicato un riciclo meccanico intensivo ma si cercava di separare ed estrarre solo plastiche nobili, oggi la consapevolezza ambientale e la necessità di ridurre il conferimento di rifiuti nelle discariche, ha imposto un uso sempre più massiccio dei polimeri da post consumo riciclati per la creazione di nuovi prodotti finiti, realizzando il più possibile la circolarità della filiera. Non è stata una svolta improvvisa, c’è voluto tempo per sovvertire il preconcetto culturale che un prodotto fatto con i polimeri riciclati fosse di seconda categoria rispetto ad uno fatto con materia prima vergine. Quando l’opinione pubblica ha sdoganato l’uso delle materie prime riciclate come elemento necessario e insostituibile della nostra vita, la domanda è cresciuta in modo esponenziale. Non c’è dubbio che, dal punto di vista industriale, il trattamento dei rifiuti plastici da post consumo per la creazione di una materia prima, che assume una nuova nobiltà estetica e strutturale nei prodotti, ha bisogno, oggi, di un approccio al riciclo decisamente più professionale e qualitativo rispetto al passato. Infatti, nel ciclo di lavoro dello scarto plastico da post consumo, che contempla la raccolta, la selezione, la macinazione, la separazione, il lavaggio e la granulazione, è interessante soffermarci sulla fase del lavaggio per capire meglio alcuni aspetti. Il concetto di lavaggio deve prevedere tre passaggi fondamentali a cui non ci si può sottrarre, se si vuole realizzare una materia prima adatta ad una produzione di un buon granulo plastico. I tre passaggi dell’attività di lavaggio sono qui riassumibili: • Lavaggio degli scarti attraverso una macchina con lavaggio forzato, che permette, attraverso l’azione dell’acqua e della rotazione centrifuga del cestello di contenimento della plastica, un distaccamento di parti inquinanti, come residui organici alimentari, sabbia, terra o altro, che altrimenti non avverrebbe in una vasca tradizionale con acqua. • Utilizzo di una vasca di decantazione in cui i materiali, che sono usciti dalla fase di lavaggio forzato, fanno un percorso studiato, in termini di velocità di movimento e di lunghezza, nella quale avviene una separazione degli scarti plastici per peso specifico. Infatti, i materiali con peso specifico più leggero come l’HDPE, LDPE, il PS e il PP, che costituiscono le famiglie di maggiore presenza nei rifiuti da post consumo, rimangono a galla, mentre quelli con il peso specifico maggiore come i materiali caricati, il PVC e altri elementi affondano. • Ultimo impianto indispensabile per concludere un buon ciclo di lavaggio delle materie plastiche da post consumo è la centrifuga. Infatti una volta lavato con energia gli scarti, averli separati da plastiche con peso specifico diverso, è assolutamente necessario, prima della produzione della materia prima finale, ridurne la concentrazione dell’umidità. Attraverso il passaggio degli scarti stessi nella centrifuga è possibile abbattere percentuali di umidità elevate che causano molti problemi, quali il degrado del polimero, la creazione di difetti estetici sul prodotto finito ed una sostanziale riduzione delle prestazioni meccaniche. La fase di lavaggio, nelle attività di riciclo dei materiali da post consumo, ha visto spesso affermarsi una sbagliata teoria definibile della “sciacquatura”, dove il processo prevedeva l’immersione del macinato plastico in vasche con una bassa qualità dell’acqua, una elevata velocità di flottazione degli scarti e una lunghezza della vasca non adeguata. Tutto questo si rifletteva in un deciso risparmio economico, un aumento della produzione oraria del reparto ma con una bassa o bassissima qualità del futuro polimero. Se, a parziale difesa di questo approccio, possiamo ricordare che nel passato i polimeri che derivavano dagli scarti da post consumo erano impiegati solo per prodotti di bassa qualità, dobbiamo però ricordare che oggi, ci si aspetta una qualità più alta da questa famiglia di polimeri in quanto è aumentata la platea di utilizzo. Un basso livello qualitativo di processo in fase di lavaggio, separazione ed asciugatura, porta inevitabilmente con sé anche il problema degli odori delle plastiche da post consumo. Se abbiamo parlato in precedenza di aspetti negativi legati alla meccanica e all’estetica dei prodotti, risparmiare tempo e tecnologia nelle 3 fasi che costituiscono il lavaggio, incrementa in modo considerevole l’odore sgradevole nei prodotti finiti realizzati con polimeri che hanno subito un processo di lavaggio scadente. La presenza di odori pungenti e persistenti nei prodotti finiti, comporta non solo la riduzione delle vendite in termini quantitativi, ma porta anche al deprezzamento dell’articolo stesso, con una riduzione dei margini di contribuzione dell’azienda.Categoria: notizie - tecnica - plastica - riciclo - post consumo - lavaggio
SCOPRI DI PIU'